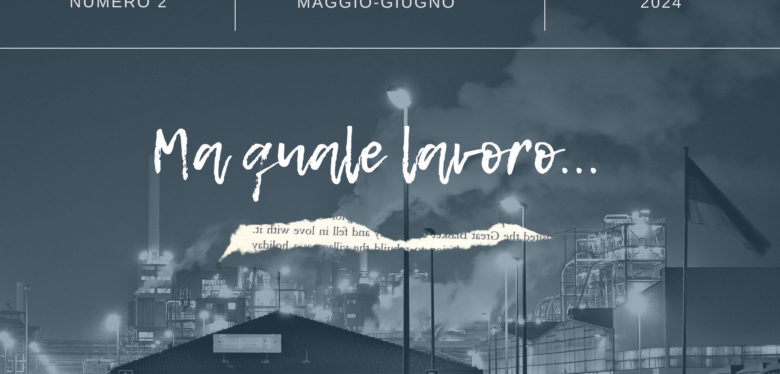Trasformazioni economiche-sociali dal secondo dopoguerra a oggi
Vi siete mai chiesti quanto il passato possa influenzare il presente? Oppure quali siano stati i cambiamenti e le trasformazioni della società italiana dall’immediato secondo dopoguerra fino ai giorni nostri?
Il secondo dopoguerra lo possiamo definire una fase di ricostruzione in diversi aspetti della società italiana: dall’aspetto istituzionale attraverso il famoso referendum Monarchia vs. Repubblica che ha avuto come conseguenza la nascita dell’attuale costituzione italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948, fino ad arrivare all’aspetto economico-sociale delle lotte operaie che hanno caratterizzato la seconda metà del XX secolo.
Dalla seconda metà degli anni 50 in poi, l’industria italiana ha registrato un certo avanzamento nei settori dell’acciaio, dell’automobile e del tessile, ma tale progresso si concentrava maggiormente nelle regioni del Nord e in particolare nel triangolo industriale del Nord-Ovest, accrescendo sempre di più la disparità con le regioni del Sud, portando come risultato la migrazione interna degli italiani che scappavano dalle campagne meridionali verso le città del Nord.
Nonostante tali cambiamenti che andavano a verificarsi nell’Italia nord-occidentale, la maggior parte dei cittadini viveva grazie ai settori lavorativi tradizionali quali: agricoltura, pubblica amministrazione o piccole aziende. Le cause prevalenti di tale fenomeno sono da ricercare nelle condizioni in cui la popolazione italiana versava: in particolar modo vi era una scarsa fertilità delle terre nel Sud, la sottoccupazione cronica, il fallimento della riforma agricola del 1950, che aveva come obiettivo quello di redistribuire equamente la terra – tra i contadini e i grandi proprietari terrieri – e al contempo migliorarla. Eppure, questa riforma andò incontro a diverse resistenze, una delle quali riguardava il dissenso dei ricchi proprietari terrieri. Il basso tenore di vita si riscontrava, ad esempio, considerando che la maggior parte delle case italiane nei primi anni ’50 non possedeva acqua potabile, servizi igienici privati e l’elettricità. Oltre alla migrazione interna sopra citata, dobbiamo menzionare quella europea, come riporta la statistica Emigrati italiani: dove e quanti in 140 anni, gli italiani che hanno lasciato il paese tra il 1861 e il 1985 sono stati circa 29 milioni, e quelli che si sono stabilizzati in modo permanente all’estero 18.761.000.
I fattori principali di questo fenomeno sono prevalentemente da ricercare nelle disuguaglianze che i lavoratori italiani dovevano affrontare, l’Italia degli anni 1950-60 doveva fare i conti con le sfide della ricostruzione post-bellica. Nonostante il boom economico di quegli anni, le regioni italiane specialmente il cosiddetto Mezzogiorno – che comprendeva le regioni italiane meridionali e quelle insulari tra cui: Sicilia, Calabria e Campania – versano in condizioni di povertà assoluta e mancanza di posti di lavoro.
Ad oggi, secondo quanto riportato dall’Istat sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie 2021-2022, nel 2022 poco meno di un quarto della popolazione (24,4%) è a rischio di povertà o esclusione sociale. Non dobbiamo pensare che la povertà colpisca solo chi attualmente si trova in una condizione di disoccupazione, la realtà è differente, il mercato del lavoro offre stipendi irrisori che non permettono a molti individui di arrivare a fine mese. Circa 1,6 milioni di italiani hanno un reddito annuo lordo superiore a 60.000 euro; 22,7 milioni di italiani non superano i 20.000 euro. Su 40,5 milioni di contribuenti, il 4% dichiara più di 2.850 euro netti al mese, mentre il 56% dichiara meno di 1.300 euro netti al mese secondo il portale “Italia in dati”.
Un altro dato da menzionare è quello riportato dalla relazione di Banco Alimentare secondo cui “il 10% della popolazione in Italia è così povera da non potersi permettere pasti regolari ed equilibrati” e “sempre più̀ persone non possono permettersi un pasto con una componente proteica ogni due giorni, e questo dato è più̀ che raddoppiato dal 2007 ad oggi”.
Queste caratteristiche del mercato del lavoro italiano trovano una valvola di sfogo costituita dall’emigrazione, che a differenza del secolo scorso, viene definita “fuga di cervelli”, ma perché tale denominazione? Chi sono i cervelli in fuga? Se negli anni che vanno dal secondo dopoguerra al boom economico, l’emigrazione era costituita prevalentemente da manodopera non qualificata, l’Italia del XXI secolo, vede lavoratori di alta specializzazione professionale fuggire dal Paese per recarsi in Paesi che tutelano maggiormente le condizioni lavorative e il benessere del lavoratore. Secondo l’Istat, “i giovani fra i 25 e i 34 anni espatriati fra 2012 e 2021 sono circa 337mila, di cui oltre 120mila laureati.”
Ma quali sono i fattori che spingono i giovani a lasciare la madrepatria? Sicuramente la migliore retribuzione, la possibilità̀ di fare carriera, le aspettative sulle condizioni di vita più convenienti.
Precedentemente ho parlato della situazione delle regioni del Sud Italia durante il periodo post-Seconda guerra mondiale, situazione assai preoccupante: tale condizione sarà cambiata settant’anni dopo? La risposta è negativa.
Comparando le regioni del Sud con quelle del Nord, il divario persiste nel tempo. Secondo le ultime informazioni rilasciate da Confcommercio, negli ultimi venticinque anni, c’è stato un calo del Pil (prodotto interno lordo) causato dallo spopolamento, carenza di controlli e lavoro irregolare. I giovani tendono ad emigrare al Nord cercando migliori possibilità di vita, sempre secondo l’Istat, il tasso di occupazione per le donne laureate è del 44% al Sud rispetto al 70% al Nord.
Come abbiamo visto fin qui, nonostante il mutamento delle epoche e dei diversi contesti economici-sociali della società̀ italiana, una caratteristica rilevante in ciascun periodo è l’insicurezza esistenziale che alcune persone si ritrovano ad affrontare, costituendo tutt’oggi un problema al quale bisognerebbe prestare più attenzione.