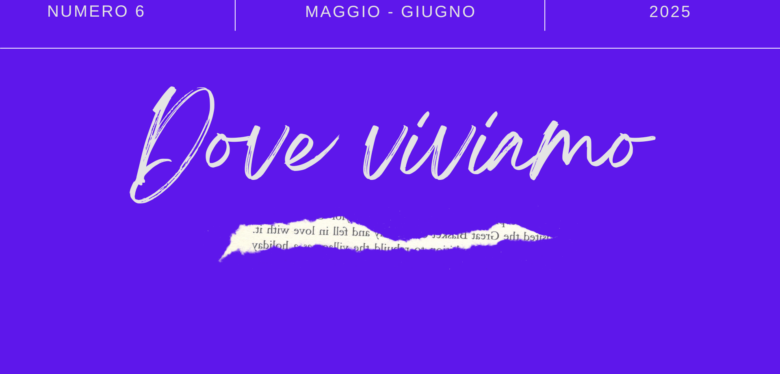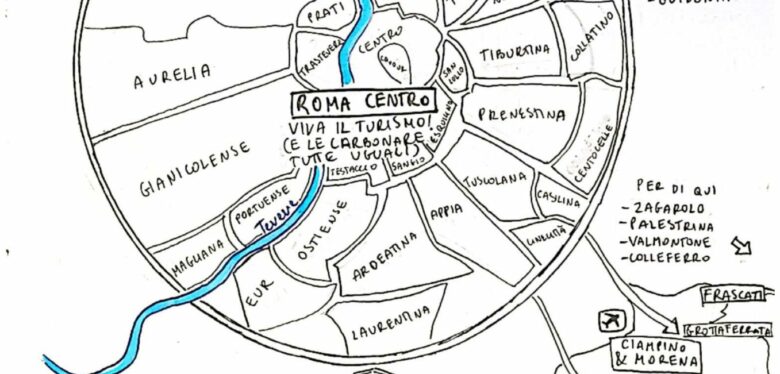Vivere in cooperativa
Vivo a Milano da sempre, conosco questa città come le mie tasche. Ho avuto il privilegio di nascere qui, ma nonostante questo ho dovuto comunque adattarmi alla realtà della metropoli. Può sembrare invisibile quanto questa città possa essere ipocrita: guardiamo con orgoglio tutte le riqualificazioni del nostro quartiere, la nuova metro che ci porta fino a Linate senza chiederci se non ci sarebbero altre priorità.
Parliamo di una città il cui costo della vita diventa ogni giorno più insostenibile, sovrastata dal problema del canone degli affitti, dall’aumento costante della domanda di case che sembra corrispondere solo a un aumento dei prezzi. Sembra impossibile non sentirne parlare ogni giorno, ma spesso il problema non ci riguarda, forse non è un problema di tutti quello di trovare un posto nella metropoli.
Proprio ragionando sull’idea che sia difficile trovare un posto, un luogo che possa essere chiamato casa, interviene DAR: una cooperativa di abitanti che nasce nel 1991 e che si occupa da trent’anni di offrire alloggi in affitto per persone che fanno fatica a trovare un posto nell’area milanese.
Volevo sapere di più sulla storia di questa cooperativa, sull’impatto che questa ha lasciato nella mia città e nel mio quartiere. Mi sono recata nella sede principale, in Stadera, un quartiere nella periferia di Milano sud, dove sono cresciuta. Al piano terra del primo complesso di case popolari mi accoglie Sara Travaglini, presidentessa della cooperativa, che fa parte di DAR dal 2005.
La prima cosa che le ho chiesto è di raccontarmi come nasce DAR e soprattutto, cosa significa. Sara mi racconta che dal primo giorno la cooperativa cerca di rispondere proprio alla necessità di trovare un’abitazione alle persone che si trovano in situazioni di difficoltà. Negli anni novanta questo si riferiva prevalentemente a una popolazione immigrata, proponendo a questa una soluzione abitativa stabile. Proprio per questo, il nome DAR è la traduzione di “casa” in arabo, per essere un punto di riferimento per una flusso migratorio maggioritario. La presidentessa mi dice subito che in realtà la fascia interessata all’offerta di DAR è variata molto nel tempo: a oggi non sono solo immigrati a rivolgersi alla cooperativa, ma tutti coloro che hanno un reddito che non gli permette di stare al passo con il mercato immobiliare milanese. Non fermiamoci a una generalizzazione istantanea: questa necessità negli anni si è estesa a una fascia di redditi sempre più estesa.
Quello che mi spiega subito Sara è che non è solo un bisogno materiale quello a cui DAR vuole rispondere, ma è anche quello di integrazione in uno spazio da poter davvero chiamare casa, intorno al quale creare delle relazioni solide.
In questi trent’anni la cooperativa ha lavorato per costruire un’offerta accessibile attraverso il recupero di patrimonio pubblico, grazie alle convenzioni con il comune di Milano e in particolare con l’ALER. Nel 2004 DAR porta a conclusione il progetto in Stadera, un primo investimento molto considerevole per la cooperativa, da cui parte il progetto di DAR di gestione sociale. Sara mi spiega che l’intervento di DAR non finisce con l’assegnazione di un appartamento, ma si spinge nel gestire anche l’abitare, con un approccio di ospitalità solidale.
I progetti che accompagnano l’abitare nella cooperativa sono volti a migliorare la convivenza e, come dice Sara, a trovare insieme delle soluzioni alle difficoltà del singolo, per aumentare la coesione tra persone diverse.
Il primo progetto di cui parliamo si riferisce proprio al tema del saper abitare: nasce nello stabile in Stadera insieme all’unità locale del “Centro per la salute del bambino”. Rispondendo alla necessità di educare i più piccoli che giocano nei cortili dei palazzi, si propone di educare all’uso dello spazio collettivo, ma ha riscontrato successo anche nel creare un luogo di incontro per le famiglie.
Nella discussione con Sara emerge spesso questo parallelismo l’obiettivo di DAR: rispondere a delle necessità materiali e concrete ma affiancare il percorso a una dimensione sociale e culturale. Coerentemente con questo proposito Sara mi ha raccontato di un progetto che le è rimasto a cuore: “Energia in Corte”, nato dopo l’aumento dei costi dell’energia tra il 2021 e il 2022 che hanno avuto un impatto significativo su molti e che hanno reso per le famiglie con i redditi più incerti meno sostenibile il costo della casa.
DAR ha cercato di rispondere a questa difficoltà iniziando in primo luogo una collaborazione con SNAM, fondazione che agisce sul campo per contrastare la povertà energetica. Il progetto era rivolto agli abitanti del quartiere di Milano sud, che hanno beneficiato di attività di sensibilizzazione sul tema. A oggi ci sono due membri della cooperativa che sono diventati tutor energetici e che supportano le famiglie nella comprensione dei loro comportamenti e nell’individuazione di possibili situazioni di risparmio. Insieme sono stati organizzati incontri di sensibilizzazione e una festa per festeggiare il progetto. Come dice Sara, a DAR c’è sempre un’occasione buona per fare una festa.
Quello che mi è venuto spontaneo chiedere è come avviene concretamente questo processo di assegnazione e in base a quale criterio viene offerto un alloggio. Sara mi spiega che agli albori della cooperativa si cercava di far prevalere le richieste più urgenti, creando una graduatoria. Ma davanti alla diversità delle domande non è sempre chiaro quale richiesta sia più urgente di un’altra. Per questo motivo il criterio di DAR è quello di rispettare l’anzianità della richiesta dei soci della cooperativa.
Ad oggi però, questa lista è chiusa. Questo perché in assenza di finanziamenti e una mobilità interna estremamente bassa, non vi sono più spazi da ristrutturare e da mettere a disposizione per i nuovi richiedenti. I tempi di aspettativa per un’abitazione arrivano quasi a dieci anni, e quindi, coerentemente con il proposito di DAR di accontentare i propri soci, si è deciso di chiudere questa lista.
Sara mi spiega che ovviamente la cooperativa risente molto delle politiche pubbliche del nostro paese rispetto al problema abitativo. Mi racconta che l’anno scorso DAR ha avuto uno scambio con l’associazione francese AFEV rispetto a un progetto riguardante l’abitare giovanile collaborativo. Il contrasto con la realtà francese è lampante, in quanto per le politiche pubbliche francesi sull’abitare vi sono dei finanziamenti ad hoc. Nel caso italiano invece risulta più difficile creare un’organizzazione che possa resistere nel tempo in maniera costantemente efficace e supportata: le soluzioni che vengono proposte dalle associazioni non vengono mai sistematizzate in politiche pubbliche ma rimangono una somma di sperimentazioni. Ovviamente da un lato questo può far emergere le differenze tra i vari contesti, ma non riesce mai a trovare una soluzione definitiva.
Il percorso della cooperativa è ancora lungo, nonostante tutti i traguardi raggiunti e tutte le famiglie che hanno trovato un posto da chiamare casa. A oggi DAR cerca ancora volontari che possano aiutare nelle attività di ospitalità solidale, come il doposcuola, il teatro nei quartieri popolari di Milano. Quartieri tra cui rientra il mio, che secondo Sara è sempre più diviso tra un blocco popolare e una parte che sembra in costante riqualificazione, dove vengono aperti ogni mese nuovi bar, nuovi negozi e ristoranti che non hanno una reale funzione nel quartiere.