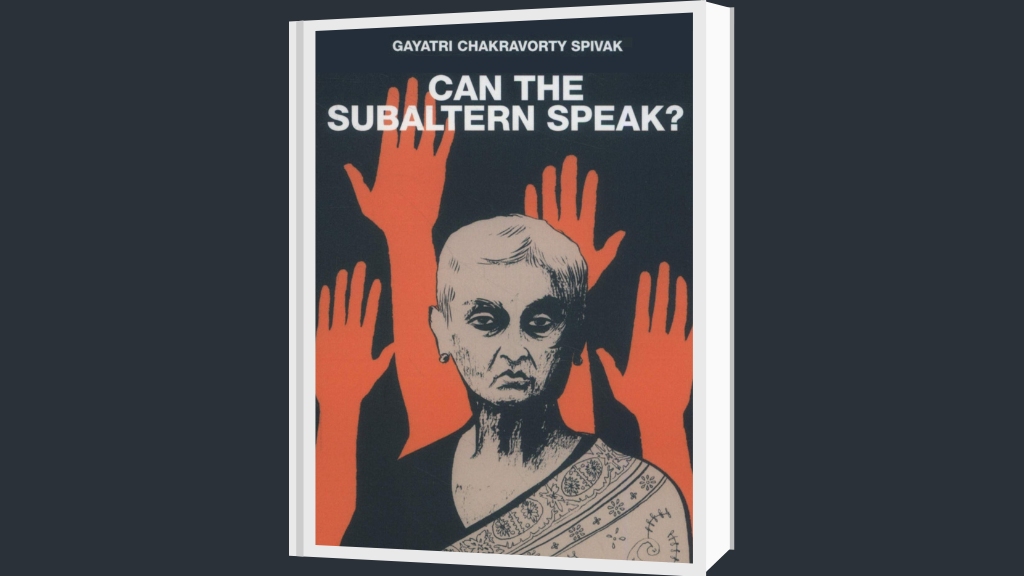Rivendicare il proprio spazio narrativo: la prospettiva subalternista
Durante la prima metà dell’Ottocento, nella regione indiana del basso Himalaya conosciuta con il nome di Sirmur, accadde un fatto particolarmente curioso, di cui siamo casualmente testimoni grazie alle poche righe presenti negli archivi coloniali di quel periodo. Il Capitano Birch, addetto al controllo della regione del Sirmur per conto del governo Britannico, esprimeva la sua apprensione in merito alla richiesta della Rani (ovvero la regina del luogo, consorte del Rajah cui i colonizzatori avevano usurpato il trono) di compiere il sati, nonostante il marito fosse ancora in vita. Il sati è un rituale indù, diffuso solo in alcune regioni dell’India, secondo il quale la vedova per devozione coniugale dovrebbe autoimmolarsi accanto al cadavere del marito nella pira creata per lui, e farsi dunque ardere viva.
Tra le pagine dell’archivio coloniale si intuisce come il Capitano Birch chiedesse l’intercessione del governo Inglese al fine di “impedire una tale barbarie”, e di come abbia infine fatto leva sulla necessità del figlio della Rani, ancora minorenne, di avere la madre al suo fianco, in modo da farla desistere. Difatti, la Rani non compì mai il sati e morì per cause naturali molti anni dopo.
La storia della Rani di Sirmur apre le porte a un dibattito complesso di cui con ogni probabilità non esiste alcuna risoluzione: è giusto che ella sacrificasse la sua vita pur di onorare il marito? La sua era davvero un’espressione di libera volontà? È lecito frapporsi acriticamente alle usanze di una cultura a noi estranea?
Tuttavia, ciò che appare particolarmente curioso di questo avvenimento storico poco noto, è un altro dettaglio che fa capo alla complessità della vicenda: l’assoluta assenza, in tutti i documenti d’archivio, di una qualsiasi testimonianza diretta della volontà della Rani di Sirmur. La sua figura occupa in questo frangente una posizione che non è facile da inquadrare: da un lato, è vittima di una atavica imposizione patriarcale che vorrebbe la sua vita, così come la sua morte, indissolubilmente dipendenti da quelle del marito; dall’altro, pur nel tentativo di esprimere una sua libera volontà, la sua parola risulta muta, poiché la donna ha come unici portavoce degli uomini bianchi, colonizzatori, giunti nella sua terra natia con la pretesa di civilizzare delle genti considerate primitive, sostituendosi ad esse.
La filosofa indiana Gayatri Chakravorty Spivak ha assunto la storia dimenticata della Rani di Sirmur come uno dei paradigmi da cui muove la sua riflessione sulla condizione della donna povera del sud del mondo, dal momento in cui i colonizzatori occidentali lasciarono le terre conquistate.
Spivak nasce a Calcutta nel 1942, facendo parte della prima generazione nata dopo l’indipendenza indiana. Cresce in una famiglia colta e benestante, la cui influenza sarà determinante per lo sviluppo del suo pensiero: circondata da ideali di stampo marxista, viene subito abituata a guardare con sospetto e ribellarsi al sistema delle caste e alla condizione di subalternità delle donne indiane. La sua produzione è variegata, ma tra i suoi contributi che in maniera più incisiva hanno segnato lo sviluppo del pensiero contemporaneo, la tematizzazione della figura della “donna subalterna” è certamente ciò che ha reso Spivak celebre a livello globale.
Per comprendere chi sia la donna subalterna, è necessario innanzitutto capire che cosa si intenda con il termine subalternità. Spivak riprende tale concetto direttamente dall’analisi sviluppata da Antonio Gramsci in seno alla Questione Meridionale, ambito nel quale il filosofo sardo presenta le “classi subalterne” come insieme composito di tutte le classi sociali minoritarie (dal proletariato urbano sino alla classe contadina) che pur nella loro diversità sono accomunate dal fatto di essere sottomesse a livello politico, sociale e addirittura narrativo alla classe dominante, rappresentata in questo caso dalla borghesia del Settentrione italiano. Tale concezione è poi stata ripresa, negli anni Settanta del Novecento, dagli studi postcoloniali sviluppatisi in India e attribuita alla condizione di oppressione delle popolazioni autoctone indiane (i Subalterni, appunto) sottomesse allo strapotere dell’imperialismo Britannico.
Ma la donna indiana, che è totalmente assente nella prima riflessione sulla subalternità, vive una condizione ancor più particolare e ambigua. Come è già stato notato, la Subalterna non solo è soggetta infatti all’oppressione proveniente dal retaggio culturale del patriarcato indiano, ma è anche sottoposta alla paternalistica (e razzista) pretesa dei colonizzatori occidentali di porsi come – nelle parole di Spivak – “uomini bianchi che salvano donne nere da uomini neri”. La condizione di oppressione della Subalterna può, alla luce di ciò, essere definita accuratamente a partire da una prospettiva spaziale. Essa infatti non occupa tanto una posizione marginale nella società attuale (in quanto se così fosse continuerebbe pure a far parte di essa), ma bensì totalmente estrinseca alla società stessa, poiché non esistono parametri sociali, politici, culturali e narrativi che consentono alla Subalterna di autorappresentarsi così come di poter essere ascoltata in maniera autentica.
Ciò che intende fare Spivak è sottolineare come la società odierna sia strutturata in una maniera tale da non consentire alla donna più povera del sud del mondo, l’ultima tra gli ultimi, di trovare le proprie possibilità di esistenza, poiché le strutture del mondo in cui vive non glielo permettono.
La conseguenza è l’impossibilità di un qualsiasi rapporto etico autentico con essa: la Subalterna abita uno spazio senza identità, dunque ciò che preoccupa maggiormente Spivak della sua caratterizzazione non è tanto la condizione sociopolitica minoritaria nella quale è relegata (aspetto comunque di notevole importanza), quanto piuttosto la totale impossibilità, per lei, di autodefinirsi secondo dei criteri autonomi che le consentano di essere riconosciuta dal mondo che la circonda in maniera rigorosa. Ciò appare evidente in quella che è la caratteristica peculiare individuata da Spivak nella Subalterna, ovvero la sua impossibilità di parlare. Nel suo saggio-manifesto Can the Subaltern Speak? Spivak conclude lapidariamente con l’affermazione “la subalterna non può parlare”, non certo per una sua fisiologica incapacità di locuzione, ma per via di una strutturale impossibilità di rappresentazione della donna povera del sud del mondo che possa essere slegata dai tentativi occidentali di sussumere la sua figura al di sotto di parametri inautentici e soprattutto eurocentrici.
Per arrivare a tale conclusione, la filosofa ha condotto all’interno della sua opera principale, Critica della Ragione postcoloniale (1999), una serrata analisi di tutti i campi del sapere all’interno dei quali la donna subalterna è forclusa, ovvero introdotta solo superficialmente all’interno della riflessione contemporanea e prontamente rimossa. Il fulcro di questo lavoro, caposaldo degli studi femministi intersezionali più recenti, è dimostrare come il sapere contemporaneo affondi le sue radici su basi retoriche, valide solo da una prospettiva occidentale, che dunque escludono progressivamente ogni possibilità di inclusione delle persone considerate “altre”, le quali sono state sempre capillarmente invisibilizzate e silenziate.
Tale metodo conoscitivo è stato talmente normalizzato nel corso della storia del pensiero da diventare un penoso automatismo, attualmente involontario. Ma come ricorda la filosofa canadese Sophia Moreau, la discriminazione non è veicolata solo attraverso comportamenti agiti intenzionalmente. La maggior parte parte delle discriminazioni infatti si possono rinvenire in comportamenti apparentemente benevoli e involontari che, proprio perché passano inosservati, consentono il mantenimento dello status quo ed evidenziano una delle cause più radicate della discriminazione: la negligenza sistemica verso le necessità di rappresentazione delle categorie marginalizzate.
Al fine di sovvertire tale condizione sociale, si rivela dunque necessario per Spivak ripartire da una prospettiva pluralista, che sia in grado di far entrare in gioco le esperienze delle persone marginalizzate senza cadere nell’errore della generalizzazione. Una prospettiva che possiamo definire subalternista,+ e che abbia come base la valorizzazione autentica delle singole persone. Per fare ciò, Spivak fa riferimento a due possibilità di emancipazione, per le quali è debitrice del lavoro del filosofo Jaques Derrida: il decostruzionismo e la scrittura. Attraverso la pratica decostruttiva, infatti, è possibile sottoporre a critica in maniera minuziosa ogni aspetto del pensiero contemporaneo fondato su basi escludenti ed etnocentriche, e lasciarne finalmente scoperte le fallacie. A partire da ciò, è attraverso il recupero della parola scritta e in particolare della forma autobiografica che la Subalterna può appropriarsi finalmente di uno spazio di autonomia autentico e non preimpostato, in modo da poter finalmente riscrivere la sua storia e le sue rivendicazioni attraverso ciò che le è sempre stato violentemente tolto: la sua voce.