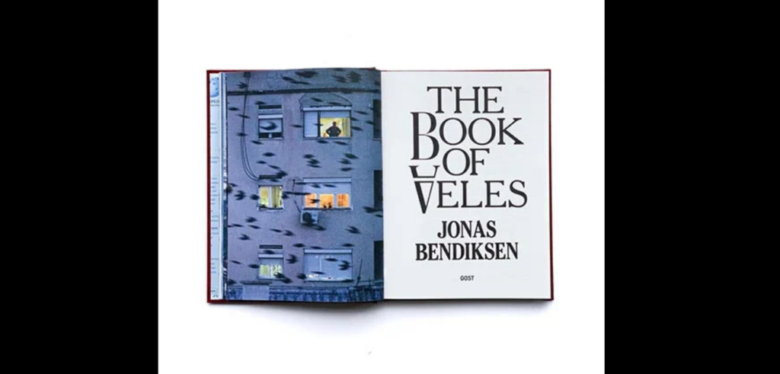Informazione in tempo di crisi: la prima vittima della guerra è la verità
In situazioni di crisi il mondo dell’informazione si trova a regolare un moto complesso di poteri politici e socioeconomici e a gestire in modo più o meno consapevole l’attivarsi di dinamiche psicologiche nuove. La situazione di crisi in cui si manifesta con più evidenza tale fenomeno è la guerra. Gli elementi centrali dei nuovi conflitti sono lo studio delle dinamiche della guerra psicologica e la gestione/manipolazione dell’informazione.
Il rapporto tra guerra e informazione è storia vecchia, ma dinamica sempre attuale, seppur con andamenti inediti che entrano, inconsapevolmente, nei meccanismi cognitivi degli individui.
L’utilizzo dell’informazione come parte integrante della strategia bellica e i suoi risultati sulla vita culturale e sulla capacità di sentire e pensare degli individui è lampante nel giornalismo che ha seguito la prima guerra del Golfo, una delle prime guerre viste in diretta televisiva, attraverso reportage e inchieste. La nuova realtà mediatica impone alle strategie belliche governative nuove pratiche, più subdole e sottili, data l’insufficienza della censura come strumento di gestione dell’informazione in periodi di crisi emergenti o guerre in corso.
Il primo conflitto del Golfo, tra l’Iraq e la coalizione di 30 paesi guidati dagli Stati Uniti sotto l’egida dell’ONU, pose l’amministrazione statunitense, sotto la leadership di George Bush, nella posizione di dover trovare un modo per convincere l’opinione pubblica che uno stato del terzo mondo fosse una minaccia imminente e la guerra l’unica alternativa valida, necessaria per debellare la potenziale prevaricazione di Saddam Hussein, dittatore iracheno di allora.
Le dinamiche che si attuarono sono simili a quelle utilizzate per i dispositivi pubblicitari: per vendere un prodotto, non si usano argomenti razionali, bensì si punta all’irrazionalità del pubblico.
È il 1° ottobre 1990 quando un’operazione mediatica iniziò a preparare l’opinione pubblica ad un intervento militare statunitense contro l’Iraq. Nayirah Al Sabah, quindicenne volontaria di un ospedale nel Kuwait, si rivolge, con le lacrime agli occhi e le parole spezzate dai singhiozzi, al congresso americano. Illustra gli orrori commessi dalle truppe irachene, facendo riferimento a un particolare evento verificatosi nel suo ospedale: l’irruzione dei soldati iracheni nel reparto maternità, con i bambini prelevati dalle incubatrici e lasciati morire sul pavimento. Una storia che destò l’indignazione dell’opinione pubblica. Fu inviata a più di settecento stazioni televisive e citata più volte dallo stesso presidente George Bush. Tutto falso. Era la figlia di un ambasciatore del Kuwait negli USA e fu ingaggiata dall’Hill and Knowlton, società di pubbliche relazioni, che collaborava con l’associazione Citizen for free Iraq.
Tra il ’90 e il ’91 l’opinione pubblica si illuse di seguire in diretta il conflitto iracheno, di ricevere le notizie in modo imparziale, fiduciosi dei reportage e delle inchieste. Il problema dell’informazione è che assume forma e contenuto diversi a seconda del paese in cui è prodotta e diffusa: i cittadini rischiano così di essere esposti ad un’informazione che credono essere oggettiva, ma che si rivela essere parziale.
Nella prima guerra del Golfo solo un’emittente poteva trasmettere da Baghdad, la CNN, rete televisiva statunitense che divenne fonte principale delle notizie e delle immagini del conflitto in corso. La narrazione era costruita su misura dalle autorità governative e militari statunitensi, una narrazione tendenzialmente priva di orrori e morti. Una guerra asettica, umanitaria e chirurgica nel colpire gli obiettivi militari.
Con il secondo conflitto iracheno, iniziato nel 2003, le dinamiche mutarono. La tecnologia satellitare esplose: qualunque giornalista poteva riprendere con il cellulare, e nacquero le emittenti arabe, tra cui la nota Al Jazeera che ha rivoluzionato l’informazione di guerra. L’informazione araba spesso contraddiceva quella americana e offriva un punto di vista nuovo sulla guerra: metteva in primo piano le atrocità belliche e lo stato continuo di frustrazione a cui erano sottoposte le popolazioni coinvolte.
L’amministrazione americana necessitava quindi di una strategia. Decise allora di arruolare gli embedded, giornalisti addestrati che vivono a stretto contatto con l’esercito, condividendo paure ed altre emozioni. Fu una mossa acuta poiché la narrazione che ne risultava appariva agli occhi dei lettori come informazione diretta e reale, ma al contempo era un’informazione che partiva da un punto di vista prettamente militare e americano, tendente a escludere il punto di vista civile della guerra, oltre ai vincoli sottoposti dal regolamento del Dipartimento della Difesa USA, il quale prevedeva la possibilità di restrizioni giornalistiche qualora il comandante dell’unità militare lo ritenesse necessario per motivi di sicurezza.
D’altronde è anche vero che qualsiasi narrazione è la rappresentazione della realtà filtrata dagli occhi dell’autore, ma con l’istituzione di un giornalismo ministeriale si rischia che la narrazione sia distorta in partenza e assuma la forma desiderata dalle autorità governative. Il giornalismo embedded si rivelò un’arma vincente per la conquista dell’opinione pubblica statunitense. I cittadini americani, rassicurati dall’ufficialità delle informazioni, si convinsero della natura missionaria della guerra narrata dai giornalisti embedded.
Le narrazioni del secondo conflitto iracheno furono fondamentalmente tre: quella americana, con i giornalisti embedded che presentarono la guerra come asettica e necessaria; quella araba che la presentò come crudele, straziante, ingiusta; quella europea che attingeva a entrambe le narrazioni, motivo per il quale l’opinione pubblica europea fu più scettica di quella americana nei confronti del conflitto.
A contrastare la narrazione ufficiale del giornalismo embedded si sviluppò anche un’altra tipologia di giornalismo, il citizen journalism: informazioni e reportage da persone comuni, non necessariamente giornalisti o esperti nel settore, che vivono nelle zone di conflitto o vi sono presenti per altri motivi. Un nuovo modo di rappresentare la guerra, il suo aspetto civile, una visione colma di paure e sensazioni personali.
Tale fenomeno è risorsa e, contemporaneamente, danno al mondo dell’informazione: le fonti continuano ad aumentare e non sono il frutto di esigenze e giochi di potere, ma chi diffonde tali informazioni spesso non ha una preparazione tale da permettergli di comprendere gli eventi che riporta e narra. Il rischio è di fornire, ancora una volta, informazioni distorte. Inoltre, ormai è evidente che in situazioni di forte incertezza, pericolo o potenziale minaccia vi sia il rischio di diffondere notizie distorte o voci non verificate.
È un meccanismo naturale: in assenza di informazioni, le notizie non verificate ci aiutano a dare un senso a ciò che ci circonda riempiendo i vuoti informativi. Sono una valvola di sfogo. “In guerra, la verità è la prima vittima”, pronunciò il tragediografo Eschilo. Era vero nel 400 a.C ed è valido tutt’ora nel 2020.